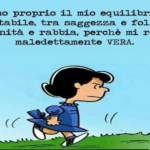Per gli antichi, i sogni avevano un’importanza decisiva: erano il tramite con gli dei, con gli antenati, con l’aldilà. Furono soprattutto i greci, a trattare approfonditamente l’argomento, dedicando ai sogni un’attenzione particolare. Attraverso i sogni, si poteva sperare di entrare in comunicazione con la divinità, si pensi ad esempio ai templi dedicati ad Asclepio, dio della medicina, presso i quali i greci passavano la notte per ricevere dal dio i suggerimenti giusti per guarire da una malattia. Attraverso i secoli, i sogni hanno ispirato l’uomo nei modi più disparati, influenzando poeti, pittori, musicisti, perfino scienziati.

Fino all’avvento della psicoanalisi, a cavallo fra ‘800 e ‘900, nessuno aveva cercato di analizzare in modo sistematico il grande tema dei sogni e del loro significato nelle nostre vite. Sigmund Freud fu il primo a vedere nei sogni una modalità di accesso all’ inconscio.
Freud nel 1895 pubblicò l’opera “L’interpretazione dei sogni”, un testo che all’epoca suscitò enorme scalpore e che contribuì, forse come nessun altro, alla diffusione della psicoanalisi nel mondo scientifico e culturale di allora. In estrema sintesi, secondo il padre della psicoanalisi, attraverso i sogni, l’inconscio esprime una serie di desideri, per lo più di natura sessuale, rimossi dalla coscienza perché inaccettabili o sconvenienti.
Nei sogni dunque, prendono forma i desideri più perversi ( si specifica che Freud utilizzò questa parola per descrivere il passaggio dal fine riproduttivo di una attività sessuale al semplice conseguimento del piacere), che possono essere soddisfatti solo attraverso l’attività onirica. Freud affermava che i sogni fossero solo un appagamento camuffato di un desiderio rimosso. Questa visione del simbolismo onirico ha influenzato l’intera cultura occidentale, ma ad un’analisi più approfondita, risulta riduttiva e insufficiente a comprendere l’enorme vastità dei contenuti psichici che si esprimono nei sogni.
Inoltre, questa sua definizione lo portò a scontrarsi con numerosi studiosi, i quali vedevano nei sogni molto di più che semplici appagamenti; uno di essi fu Carl Gustav Jung, suo discepolo, il quale riteneva che i sogni fossero condizionati dai nostri problemi, dalla nostra vita e dalla realtà circostante e che non per forza vogliono e devono essere interpretati come desideri, l’ oggetto di un sogno non per forza deve essere investito di un valore sessuale. Secondo Jung il sogno è un prodotto autonomo e significativo dell’attività psichica e cioè, non siamo noi che sogniamo, ma sono le immagini del sogno che ci vengono a trovare durante la notte. Nel sogno sono presenti elementi della psiche individuale, ed elementi della psiche collettiva. Ovvero sono presenti elementi personali, ed elementi culturali.
Secondo Jung l’inconscio non si traveste come pensava Sigmund Freud.Nel sogno non ci sono parti nascoste o ambigue. Bensì l’inconscio si manifesta con autenticità attraverso simboli e archetipi. Infine, il sogno è una sorta di teatro. Ovvero ogni personaggio del sogno (cosa o persona) è una parte del palcoscenico psichico dell’individuo. Se sogni tua madre, tuo padre o tuo marito, non stiamo parlando di loro, ma stiamo parlando di te sognatore. Tutti questi personaggi sono parti della tua psiche.

Lavorare con i sogni è un lavoro complesso, non nel senso di difficile, ma ricco di sfumature, artistico e scientifico al tempo stesso. Lavorare con i sogni è importante perchè sono una guida nei momenti difficili e oscuri della vita, quando ci si ti trova nelle nebbie del caos psichico e non si sa che direzione prendere. I sogni ci mettono in contatto con noi stessi e ci lasciano scoprire parti di noi, risorse ed elementi della personalità che non si pensava di possedere.